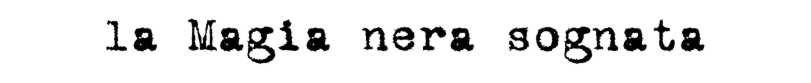



Ieri
ho fatto un sogno.
Fin qui nulla di strano. Sogno tutte le notti — almeno credo.
Il fatto è che non ricordo mai i dettagli con così tanta
precisione. È come se l’icona di questa notte — perché
di un’icona si tratta, distante, sfinita, come soltanto nei sogni
restano appese le immagini — l’avessi dipinta io stesso.
Con questo, sì, arrivo a delle conclusioni: nella mia testa (non
dico né « cervello » né « inconscio
», lascio ad altri il gusto di imporre etichette) risuona lo sciabordio
di polle multicolori — gialle, verdi, rosso-sangue, blu-notte.
Sono vasche, per quanto ne so, scavate direttamente nell’argilla
cupa che sottostà all’intrico dei miei pensieri. Sopra
di esse lampeggiano, argentee, le lingue di luce, le scariche fra sinapsi
e sinapsi. Potrei chiamarla Penelope, la mia mente, ché lassù,
nella volta remota sopra alle pozze piene di colori, fa e disfa e rifà
la sua ragnatela, incessantemente.
Ma non è questo che conta.
I colori, dicevo. Ogni notte — e ogni volta che il sonno
mi prende, che mi rapisce dal mondo che dicono sia quello « vero
» — sono allora io che immergo dita dolorose, sensibili
e arcuate come setole di pennelli costosi, dentro le vasche. Afferro
pigmenti che scivolano sulle mie braccia, che stendono un velo ora opaco,
ora lucido, sul reticolo impercettibile delle linee delle mie mani.
Le pieghe e le rughe della mia pelle — le vedo — s’impreziosiscono
di terre di Siena, di ori e turchesi; lasciano scorrere tinte sopra
altre tinte, le mischiano e le confondono in nuovi toni; sperimentano
gradazioni diverse, mai viste, e sono felici come donne anziane che
hanno scoperto un maquillage sovrumano.
Poi, ecco: con gesti sicuri, anche minuziosi, affronto una superficie
bianca, un piano vergine che esiste — o meglio, affiora dal nulla,
sospeso sopra alle pozze — da sempre, ma di cui mi accorgo soltanto
adesso. Traccio l’abbozzo del mio « dipinto » (in
quale altro modo potrei chiamarlo?): curve rapide, sinuosità
e linee scabre che, a breve, definirò di azzurro e di ocra. Solitamente
so sempre qual è il soggetto della composizione, ma — dev’essere
così che funziona — non me lo rivelo mai sùbito.
Aspetto che le forme si facciano strada da sé, che trovino spazio,
e poi vita, soltanto alla fine. Solo quando il mio polpastrello umido
di colore ha lasciato l’ultimo segno. Ed io mi ritraggo, indietreggio
con terrore sacro, davanti a figure che riconosco, che rinnegavo, sepolte
all’interno di me.
L’altra
notte, quindi, io ho dipinto di nuovo. Di quinta, una cornice rocciosa,
scura: una sagoma nera. Oltre quella, come se stessi guardando da dentro
una grotta (la caverna platonica?, oppure un frammento strappato d’una
parete domestica?) su di uno strapiombo, è apparsa una donna appoggiata
ad un grande sasso, come un sostegno messo lì per lei, levigatamente
tranquillo. Sullo sfondo una distesa marina che, in qualche punto —
l’orizzonte era perso, debolmente confuso — si mescolava e
fondeva col cielo in una passata omogenea, ma nient’affatto piatta,
di note notturne d’azzurro.
La donna era nuda — ma di una nudità neutra, statuaria, per
nulla carnale e eccitante. L’immobilità, addossata al sasso-sostegno,
la congelava in un tempo assoluto. E, a confermare quell’immensa
staticità, dalla fronte spaziosa fin quasi all’altezza dell’ombelico
— cioè del filo fioco dell’orizzonte — era ricoperta
del medesimo azzurro notturno del mare-cielo dietro di lei. Come se lo
scenario, le diverse profondità dei livelli raffigurati, finissero
per accavallarsi, per sovrapporsi in una sorta di gioco di veli a due
dimensioni, annullandosi. E a niente valeva il fatto che, dall’ombelico
al pube, fino alle cosce — o dalla piega del gomito fino alla mano
dell’unico braccio visibile —, ricominciasse la pelle, sfumando
rapidamente dall’azzurro al roseo.
In quel momento credo di aver pensato — sempre che nei sogni si
possa pensare — di essere finalmente vicino: che fosse quella, proprio
e soltanto quella, l’idea del Tempo che io stavo inseguendo:
la fissità dei miti, forse, che è impastata della stessa
materia che compone le nostre divagazioni oniriche. E, come il Mito, ho
compreso che avesse bisogno d’un dettaglio in più, di un’addizione
che le donasse quella sottile, spesso inafferrabile, mutabilità
potenziale che è propria degli archetipi, delle leggende. Narrate
sempre allo stesso modo e sempre con una nuova, minuscola variante.
La colomba. L’ho disegnata io, l’ho riposta io stesso
nell’incavo accogliente fra il collo e la spalla? Oppure è
volata da chissà dove (dalla linea nascosta dell’orizzonte?,
dalla caverna oscura?), e si è accomodata lì, ad accarezzare
piumosamente la guancia azzurra della visione?
Racconterò
un mito, mi sono detto al risveglio, non appena ho riaperto gli occhi.
Un mito con una donna, e una scogliera a picco su una marina subito
dopo il tramonto, o poco prima dell’alba. Su quell’effigie
femminile, su quella figura mitica che mi guarderà priva di pupille,
ma di cui non ricorderò il nome, si poserà, lieve, una colomba.
Sarà tutto un artificio di forme che si appoggiano ad altre forme:
la roccia nera al pannello azzurro del fondo; l’immagine della donna
al sasso e all’orizzonte; il mare e il cielo alla scultura vivente
della donna… E la colomba su tutto. Raccolta nella piccola fossa
della clavicola; oppure distesa su un fianco, sopra una tela su cui è
dipinta, con due colori, una donna-statua.
In realtà non sta a me decidere dove debba posarsi una colomba.
Gli occhi, per vedere, non devono sforzarsi più di tanto. L’Impossibile,
che lo si sogni o meno, è sempre davanti a noi. E ci fissa. Magari
anche dalla superficie, apparentemente piatta, di un quadro.
NOTA
AL TESTO:
Questi appunti datati 1932, scovati fra l’enorme mole di carte e
fotografie nello studio di Bruxelles di René Magritte, sono probabilmente
alla base della creazione dell’opera intitolata La magie noire
(o, in fiammingo, Zwarte magie). Probabilmente, si è
detto, poiché alcuni esperti e la stessa M.me Georgette, moglie
e modella dell’artista, ne hanno messo in dubbio l’autenticità.
Che tale scritto possa essere falso lo dimostrerebbe che, fra le altre
cose, nessun accenno vi appare a proposito del futuro titolo dell’opera
— obiezione assai debole, a nostro avviso (ben più significativa
sarebbe invece la mancanza d’ironia del testo).
Al di là di qualsiasi disputa vale comunque la pena di evidenziare
l’accurato racconto della composizione — che il surrealista
Magritte rielaborò più volte nel corso della sua carriera
—, e l’accenno alla variante della colomba, non sempre presente
nelle diverse versioni de La magie noire.