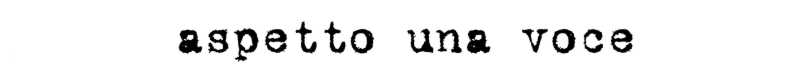

La curiosità delle ragazze affacciate alla finestra: c’è una festa laggiù, sì, c’è una festa. Come per l’ultimo giorno di scuola — quell’elettricità, quel bisogno opprimente di nuovo e di già conosciuto, e la paura di bruciare tutto, subito.
(Rammento l’ansia delle mie compagne, l’odore dolciastro del loro sudore ancora mezzo infantile. C’era, in quei giorni — quando l’anno scolastico stava per chiudersi e le comitive stavano per lasciarsi, ognuno diretto ai luoghi di villeggiatura —, come una febbre sottile che ti prendeva in mezzo alla fronte, come una foia che non ti lasciava, e se lo faceva era soltanto quando ti gettavi esausto sul letto, dopo giornate intere di ronde a vuoto per quartieri ignoti o appena sfiorati. Perlustravamo la città, le strade. Finivamo, indolenti e vigliacchi, sempre sotto le solite case, a spiare imposte accostate, tapparelle sollevate a metà. Dietro quelle strisce di legno — verdi o marroni che fossero — forse passavano, leggere e impalpabili come fantasime, le nostre amiche odorose, femmine appena dischiuse. Prigioniere eteree — le immaginavamo —, sollevate dal suolo, a scorrere a quattro dita dal fresco dei pavimenti in passeggiate di folle inquietudine. Avevano nomi comuni, ed occhiaie insolite, irripetibili e belle.)
L’aria è fresca, soave; dopo l’afa opprimente del giorno, la notte rischiara le menti fra i sorsi di vino, i sorrisi ed i baci sfuggenti. Sfilano volti indecisi nell’ombra, linee imprecise di occhi, di nasi, di bocche, avorio di denti nel buio. A tratti riprende vita la brace di una sigaretta, tra chissà quali labbra, tra chissà quali dita.
(Le dita ritmavano un disco, un motivo di quell’estate. A volte andavano a tempo, a volte no. Tradivano il nervosismo continuo di quei giorni in cui già si era altrove, e già pieni della nostalgia per le persone di sempre, quelle che avremmo presto — chi più chi meno — tradito in cerca di… Cosa? Non lo sapevamo. C’era solo quel rimescolio dentro il sangue, quasi che il sangue stesso avesse una sua intelligenza, oppure un istinto animale di sopravvivenza, una fame insaziabile. E allora, magari, non eravamo che vittime del nostro battito, di una deriva cardiaca che — era sicuro — avremmo seguito alla cieca, e che ci avrebbe fatto comunque soffrire. Ma erano sofferenze preventivate, roba da ragazzi, punture leggere. I giovani sono abituati a ricominciare ogni cosa, ogni volta.)
Aspetto una voce dall’ombra. Studio in silenzio i futuri possibili, senza capire. Segretamente prego la luna — l’ospite nella sua casa, sulla sua terrazza — perché mi accompagni alla mano-colomba che si nasconde, timida come una bimba, all’idea del mio invito, all’idea di posarsi dentro il mio palmo gentile.
(Questo aspettavo — nient’altro. Mi succede ancora, naturalmente. E ancora non provo vergogna a pregare la luna. Eppure è sempre più difficile trovare terrazze ombrose dove le colombe amino riprendere fiato. Il loro volo, con gli anni, si è fatto più breve, più basso.)